Il bello universale e naturale di Kant
A fronte di un’opera d’arte o di ogni altra manifestazione ci chiediamo se la bellezza delle cose possa essere universale o se debba essere relativizzata. Il dibattito che ne scaturisce è più che mai attuale nel nostro tempo storico, ma precedentemente le idee erano molto chiare.
Ogni genitore è orgoglioso dei propri figli, specie se ritiene che ne abbia migliorato in qualche modo la vita. E così in uno dei tre episodi di Dove vai in vacanza?

Remo ed Augusta Proietti sono felici di accettare delle ferie alternative proposte dai loro figli, non umili ed incolti lavoratori, ma menti aperte e vive che, dalla storia alla dietologia, vogliono farli passare attraverso lo straordinario patrimonio museale italiano.

Ma quello è anche l’anno della Biennale di Venezia e Remo ed Augusta vanno davvero in crisi filosofica quando, come solo Alberto Sordi ed Anna Longhi potevano fare, si trovano davanti un presunto capolavoro.

Caldo intenso, qualche chilo in più e qualche energia in meno a causa dell’età. Perché non accomodare Augusta su una robusta sedia di legno? Sarà Remo a prendere qualcosa da bere e da mangiare. Fin qui, tutto nella norma, se non fosse che la disconoscenza del luogo e l’idioma veneziano disorientano Remo e ne rallentano il ritorno. Sopraggiunge un gruppo di visitatori, quasi tutti verosimilmente stranieri, ma due attempati italiani commentano. Un tratteggio multiforme fa da cornice ad un’opera originale e vivente, un corpo adagiato come una sfera che si sprofonda verso il basso che poi s’innalza verso l’alto, come sospinta dal vento che muove la palma, varrebbe forse la pena anche di spendere diciotto milioni di lire? Secondo l’elegante narratore e la sua compagna, sì!

Il ritorno di Remo rompe l’idillio: come osano fotografare la sua signora? Chi sono e che cosa vogliono? Non è mica la donna nuda vista nelle sale precedenti, però, mamma mia, diciotto milioni! Forse sono troppi!
Sorge spontanea l’analisi del bello nel kantismo, soprattutto rispetto a due grandi elementi che nella Critica del Giudizio vengono proposti, due aggettivazioni straordinarie: il bello è universale e naturale. Nella sopravvivenza dello spirito illuministico nella ricerca scientifica, anche l’estetologia kantiana conserva il tratto dell’universalità. Il bello dovrebbe essere tale per ogni tempo, per ogni luogo, per ogni uomo del pianeta, chi non lo riconosce, è solo perché è poco educato a vedere cose del mondo belle. Ovviamente tutto sta a vedere se i mancati conoscitori del bello sono i coniugi Proietti o tutti i visitatori della Biennale di Venezia, ma questo è un altro conto. La spontaneità del bello si coglie nella sua naturalità, nel non essere artefatto, nel vederne una purezza. I visitatori ritenevano che quel corpo vivente fosse tale. Per Sordi e gentile signora, questa è follia, come la spesa di tanti milioni di lire per un possibile acquisto di Augusta. Quando vediamo un bambino, un cucciolo di una qualsivoglia specie animale, una fonte d’acqua incontaminata diciamo “che bello!” non solo per motivi estetologici, ma anche etici. Quel bello sta per puro, incontaminato: ecco perché sulle bottiglie d’acqua, anche se sono di plastica, scriviamo “naturale”, nessuno pensa che esista acqua artificiale, ma nessuno berrebbe acqua inquinata. Bambini e cuccioli, inoltre, non posseggono la malizia che la nostra età adulta ci ha purtroppo trasmesso e sono conseguentemente puri.
Parerga e Paralipomena
ll genius loci
Gli antichi Romani avevano una parola chiave che ben qualifica il rapporto tra la naturalità ed un luogo fisico: ingenium. Con essa intendevano le qualità naturali di qualcosa, la sua indole ma anche la capacità intellettuale e l’ingegno di un uomo. Il genio è chi per natura produce le opere d’arte, come la Natura, per sua stessa indole, dal nulla è capace di produrre il bello che in essa risiede. È la lezione più suggestiva di Kant, il messaggio che già i Romani volevano veicolare anche attraverso dei luoghi nel concetto di genius loci, l’entità sovrannaturale che protegge un luogo naturale. Una straordinaria testimonianza ci viene dal Vesuvio. Può un vulcano essere legato ad una divinità protettiva? Non ci dimentichiamo che le terre vesuviane sono fertili, vi si trovano delle ottime uve, dei prelibati ortaggi ed in più il mons protegge il golfo dal freddo e mitiga il clima. Nell’affresco dedicato al dio Bacco ritrovato nella Casa del Centenario di Pompei, il Vesuvio non presenta il cratere. Appare mite, quasi bonario ed i suoi effetti benevoli sulle future libagioni sono evidenti data la presenza di Bacco. I boschi, le coltivazioni della vite: qualche divinità proteggeva quel luogo e forse il 79 d. C. si dimenticherà di farlo…

Potrebbero interessarti anche…
 https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/04/foto-copertina.png
570
1364
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-04-25 05:31:262024-04-25 05:31:26Wabi-sabi: perché i Giapponesi sono perfezionisti?
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/04/foto-copertina.png
570
1364
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-04-25 05:31:262024-04-25 05:31:26Wabi-sabi: perché i Giapponesi sono perfezionisti? https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/copertina.jpg
720
1280
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-03-16 08:31:132024-04-22 11:35:05La zona d’interesse: non autori ma esecutori
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/copertina.jpg
720
1280
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-03-16 08:31:132024-04-22 11:35:05La zona d’interesse: non autori ma esecutori https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/k8ShNTAVv3kq7VvbobHKac-1200-80.jpg
300
600
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-03-02 22:37:292024-03-02 22:38:35Jurassic Park: il rapporto tra uomo e natura da Talete a Bacone
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/03/k8ShNTAVv3kq7VvbobHKac-1200-80.jpg
300
600
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-03-02 22:37:292024-03-02 22:38:35Jurassic Park: il rapporto tra uomo e natura da Talete a Bacone https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/02/copertina.jpg
450
800
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-02-24 09:22:442024-02-24 09:22:44Philadelphia: che cos’è la tolleranza?
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/02/copertina.jpg
450
800
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-02-24 09:22:442024-02-24 09:22:44Philadelphia: che cos’è la tolleranza? https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/01/copertina.jpg
368
672
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-01-20 18:45:112024-01-20 18:45:11Lo scopone scientifico: la filosofia del giocatore
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2024/01/copertina.jpg
368
672
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2024-01-20 18:45:112024-01-20 18:45:11Lo scopone scientifico: la filosofia del giocatore https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.png
434
1024
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2023-12-31 22:27:412023-12-31 22:27:41Pulp fiction: il problem solving
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.png
434
1024
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2023-12-31 22:27:412023-12-31 22:27:41Pulp fiction: il problem solving https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina-2.jpg
630
1024
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2023-12-29 21:17:042023-12-30 08:28:56Rocky IV: la fine della Guerra fredda
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina-2.jpg
630
1024
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2023-12-29 21:17:042023-12-30 08:28:56Rocky IV: la fine della Guerra fredda https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.jpg
451
640
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2023-12-23 22:31:212023-12-24 11:12:33Per grazia ricevuta. Le fedi cieche
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/12/foto-copertina.jpg
451
640
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2023-12-23 22:31:212023-12-24 11:12:33Per grazia ricevuta. Le fedi cieche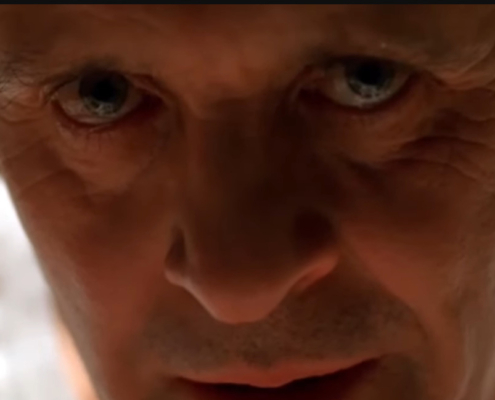 https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/08/Il-silenzio-degli-innocenti_foto-copertina.jpg
649
1208
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2023-08-26 23:32:432023-09-04 00:12:22Il silenzio degli innocenti. La semplicità ontologica e il desiderio in Marco Aurelio
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2023/08/Il-silenzio-degli-innocenti_foto-copertina.jpg
649
1208
admin@litm
https://www.likeinthemovies.it/wp-content/uploads/2021/02/Like-in-the-Movies-Logo-Payoff-300x146.png
admin@litm2023-08-26 23:32:432023-09-04 00:12:22Il silenzio degli innocenti. La semplicità ontologica e il desiderio in Marco AurelioSeguici su Facebook
Scheda del film

Regia
Alberto Sordi
Titolo originale
Dove vai in vacanza?
Durata
153 minuti
Genere
Commedia
Data di uscita
1978
Dettagli dell’opera
Titolo
Bacco e il Vesuvio
Dal lalario della Casa del Centenario
Autore
—
Tecnica
Affresco
Realizzata nel
I sec. d. C.
Ubicazione
